Nelle discipline olimpiche, tutte, il corpo è centrale. Sono nate come celebrazione di quello che il corpo, o almeno certi corpi, possono fare.
Nel nostro immaginario gli atleti sono belli, i corpi solidi, armoniosi, forti. Vicini alla perfezione a cui (temo scioccamente) tendiamo e ambiamo.
Ai corpi si chiede molto, sempre di più, ma poi non gli si dà l’attenzione e il rispetto necessari. Lo facciamo tutti, non solo gli atleti. Finché il corpo non si ribella lo usiamo e ne abusiamo, lo sfruttiamo come se fosse eterno, lo tacitiamo con medicine sintomatiche e velenose, lo consumiamo. E siamo così poco attenti che il corpo, il nostro corpo, quello che ci dà presenza e sensazioni e sentimenti, quello grazie a cui possiamo dire di essere vivi, il nostro corpo a un certo punto deve urlare o fare qualcosa di estremo per farsi sentire.
Alle Olimpiadi questo si vede, ogni tanto, negli atleti superfavoriti e che invece falliscono. Come il pattinatore Ilia Malinin caduto due volte, o la sciatrice Lindsay Vonn che somma un nuovo infortunio a quello che aveva già, tanto per fare due esempo clamorosi.
Pressioni, aspettative, lo sport come professione, gli sponsor, la fama, le sfide; tutto congiura perché dal corpo si pretenda l’impossibile.
Ma siccome il corpo siamo noi, le prestazioni, le performance, il superamento dei limiti ce li dovremmo chiedere, e non pretendere. Perché chiedere contempla che la risposta sia no, non ce la faccio, non ci arrivo; mentre la pretesa, con la sua arroganza, prevede solo il sì. Così che il no arriva come uno sgambetto, una sorpresa.
Come si dice dicesse Nelson Mandela: o vinco o imparo. E imparare è duro, ma alla fine molto più utile che vincere.





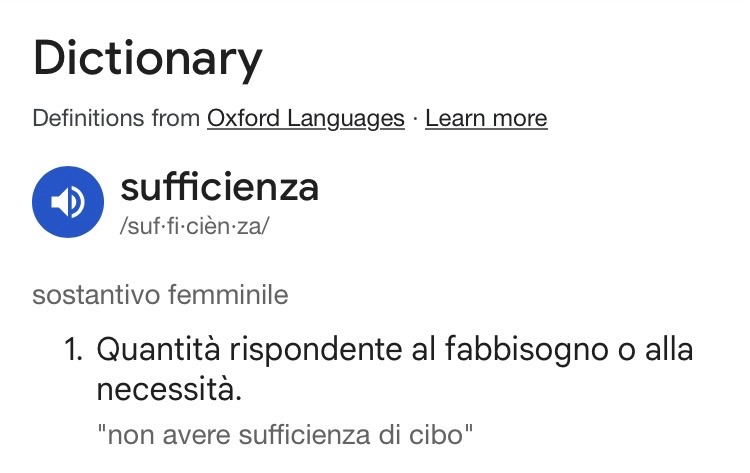
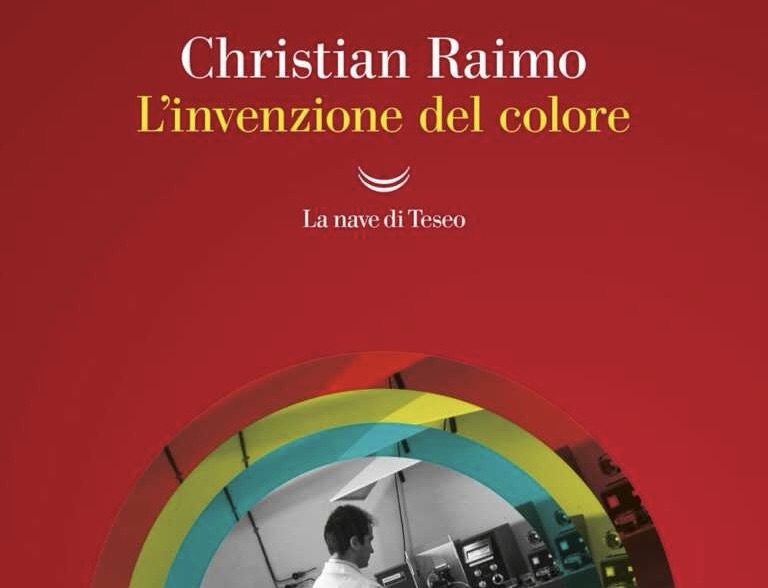
Lascia un commento